Incontrarci Nell’assenza
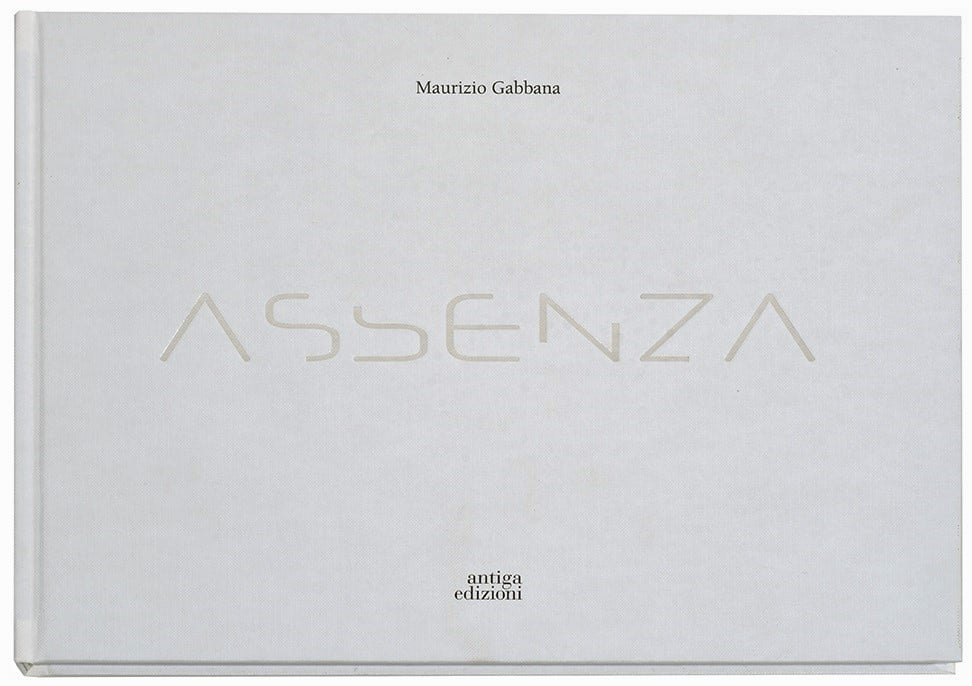
Maurizio Gabbana – Assenza, Antiga Edizioni, 2020
Incontrarci Nell’assenza Leggi tutto »
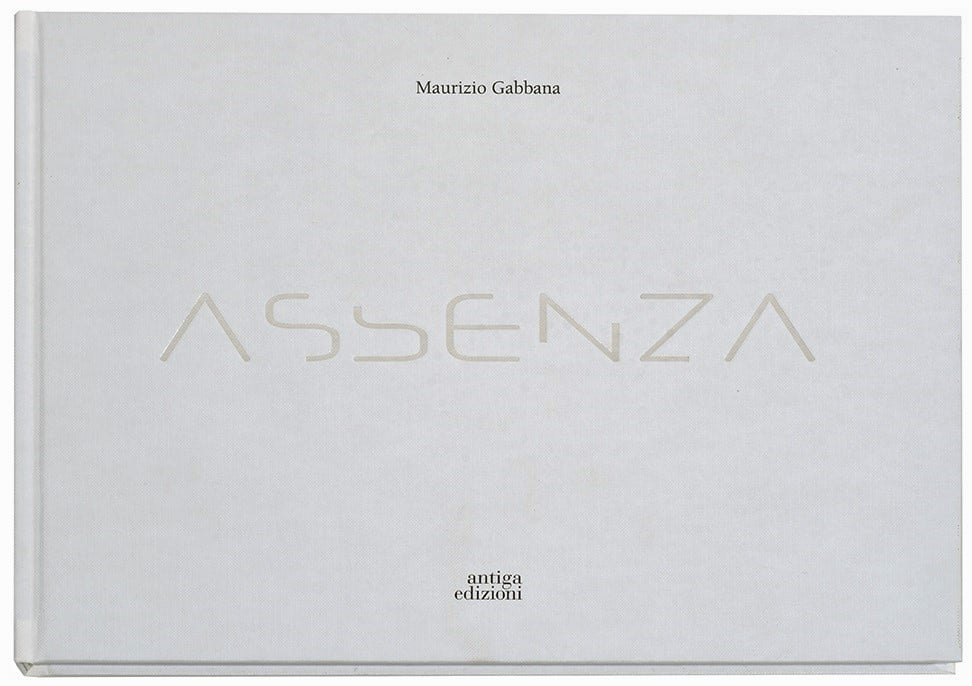
Maurizio Gabbana – Assenza, Antiga Edizioni, 2020
Incontrarci Nell’assenza Leggi tutto »
di Paolo Albani
Ogni volta che sfoglio e m’immergo nella lettura del Dante di Giampaolo Dossena (Longanesi & C. 1995, ristampato nel 2004 e nel 2020 da Tea, quest’ultima edizione anche in e-Book) resto di princisbecco, per dirla alla maniera di Collodi. In primo luogo, per l’originalità della struttura. Sono 212 capitoli, tutti numerati e con un titolo esplicativo che ha una data fra parentesi – ad esempio Il culto per Virgilio (1227 circa), I frati gaudenti (1260 circa), Far parte per se stesso (1304) – e rimandi incrociati, che, volendo, permettono una consultazione soggettiva, non lineare, con scelte di lettura a piacere. Insomma il Dante di Dossena è un’opera aperta. Si parte dal primo capitolo intitolato Preistoria, perché la vita di Dante Alighieri dovrebbe cominciare dalla creazione del mondo secondo la tradizione religiosa giudaico-cristiana, e si finisce con i Fantasmi in cui si narra dell’apparizione del fantasma di Dante in Ravenna che indica al figlio Pietro il punto del muro di casa dove sono (sarebbero) nascosti i tredici capitoli mancanti della Divina Commedia.
Ogni capitolo è ricco di riferimenti storici e letterari, una miniera di narrazioni sulla vita di personaggi conosciuti da Dante, una guida dettagliata dei luoghi geografici in gran parte visitati dal poeta fiorentino, e anche una raccolta divertente di pettegolezzi, aneddoti e collegamenti al mondo contemporaneo, voli pindarici, pur sempre stimolanti, fra epoche diverse.
Completano l’opera quattro tavole riguardanti le date relative a papi, imperatori e re di Francia, gli ultimi Hohenstaufen (da Federico I Barbarossa a Corradino), i Capetingi e gli Scaligeri, oltre a un Repertorio, utilissimo strumento per ripescare nel libro tematiche, persone e luoghi citati, nomi di personaggi quali Marx, Stalin, Manganelli, Rabelais, Gadda, Leopardi e Kant, tanto per dirne alcuni a caso, o tematiche come misoginia, pettegolezzo, barzelletta, comico involontario (riguarda le rielaborazioni delle storie di Carlo Magno e dei suoi paladini in «franco-veneto»); fra i luoghi c’è la provincia di Massa-Carrara dove sono nato io, nominata a proposito di alcuni castelli dei Malaspina lì ubicati.
Queste tavole, precisa Dossena, sono più utili che «tener sott’occhio gli schemi topografici dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, quegli orrendi imbuti, coni e cerchi concentrici».
Il Dante di Dossena è l’opera di “un lettore dotto e curioso”, di uno scrittore che ha un suo stile proprio, riconoscibile, a tratti irriverente e pungente, dispensatore di affermazioni gettate sulla pagina senza peli sulla lingua, di ricostruzioni sul vissuto dantesco che denotano un vasto bagaglio culturale da certosino. Che ha dello spaventoso.
Quella di Dossena è, come ho notato altrove, una scrittura dal sapore «lombardo», in certi frangenti al limite dello sperimentale, ma senza mai scadere nell’astruso o nell’ermetico. In una lettera degli anni Sessanta il suo amico Luciano Bianciardi annota: Dossena «ha una preparazione di prim’ordine e sa scrivere». Uno «scrittore vivacissimo» lo definisce Franco Fortini.
La frequentazione dantesca di Dossena è assidua. Nel 1999 esce da Vallardi Dante Alighieri. Commedia. Inferno in cui viene fatta un’analisi dei canti, all’interno del quadro storico in cui furono concepiti, insieme a elementi sulla vita e le opere del Sommo Poeta.
Del 1987 è il primo volume della Storia confidenziale della letteratura, titolo che trovo semplicemente meraviglioso, che va “Dalle origini a Dante”, sempre per Longanesi & C. Purtroppo questa storia “confidenziale” non va oltre il Seicento. L’incompiutezza sembra una caratteristica ricorrente dell’attività di estensore di libri dello scrittore cremonese. Qui, nella Storia confidenziale della letteratura, Dossena mette mano a un metodo innovativo, originale che permette di scoprire – così recita la nota di presentazione – come e perché a un tale è saltato in mente di scrivere una certa cosa (e se poi questa certa cosa è un capolavoro tanto meglio), e in modo confidenziale, ovvero parlando di certi vecchi libri con segretezza e discrezione, chiamando difficili i libri difficili e noiosi i libri noiosi e spiegando con franca brutalità perché certi libri bisogna leggerli e perché certi altri è meglio non leggerli.
Gran parte del primo volume della Storia confidenziale della letteratura è dedicato a Dante, e molte cose confluiranno nel volume Dante già citato.
Dossena ha una grande passione per le guide (anche il suo Dante in fin dei conti è organizzato in forma di guida, una mappa per delineare un itinerario storico-letterario dedicato all’autore della Divina Commedia), in questo campo l’apice lo raggiunge nel voluminoso I luoghi letterari. Paesaggi, opere e personaggi (uscito presso Sugar nel 1972, ristampato nel 2003 da Sylvestre Bonnard), che doveva essere il primo di tre libri rispettivamente dedicati all’Italia settentrionale, centrale e meridionale, progetto sfortunatamente ancora una volta rimasto incompiuto. È «un’opera consapevolmente personale, ma condotta secondo criteri rigorosi quanto a storia, a letteratura e a pedagogia», puntualizza Dossena, lamentando fra l’altro che nelle guide canoniche, tipo Touring Club Italiano, si dedichi «uno spazio nullo alle notizie di carattere letterario, in confronto allo spazio dedicato alle notizie di carattere artistico, storico-politico, economico ecc.».
Ne I luoghi letterari, Dante compare più volte. Lo si trova citato in città come Bologna, Genova, Noli (Savona), «uno dei quattro punti più dirupati sulla faccia della terra che Dante avesse visto», Venezia (dove «Dante avrebbe anche potuto leggere Il milione, Dante avrebbe anche potuto incontrare Marco Polo: non si sa»), Verona (Giovanni Camerana, capitano a Verona, il 3 maggio 1896 scrive il sonetto Dante in Verona, «tra il non-sense e il Prode Anselmo») e soprattutto Ravenna. In quest’ultima città, Dossena racconta, fra le altre cose (oltre alla storia delle ossa di Dante trafugate dai frati francescani), che Dante, «famoso mago» (aspetto poco conosciuto del poeta), viene consultato da uno “scientifico cittadino” proveniente da Genova per una misteriosa questione d’amore. Fonte della notizia è Franco Sacchetti (1332-1400), poeta e novelliere.
Ricorda Dossena che Dante parla di numerosi personaggi legati alla storia e alle leggende di Ravenna, città in cui muore, aggiungendo: «ma vedremo il tutto nell’appendice sull’Italia dantesca, in altro volume», anche questo disgraziatamente mai uscito.
Il Dossena, magistrale esperto di giochi, non poteva non occuparsi del Dante che gioca con la lingua. Nei tre volumi che formano la Enciclopedia dei giochi (Utet 1999), Dante ricorre in ben 67 voci.
Il Dante in veste di navigato linguista cattura l’attenzione di Dossena che segnala alcuni giochi disseminati nella Divina Commedia, e non solo (i versi danteschi che cito sono quelli della versione contenuta ne La Divina Commedia, testo critico stabilito da Giorgio Petrocchi, con una nota introduttiva sul testo della Commedia, Einaudi 1975).
L’acrostico ad esempio è presente nel Purgatorio (12. 25-63), dove le lettere VOM, ripetute a inizio di verso, formano la parola UOM[O] (la V in antico sta per U), la più superba delle creature, e il canto XII del Purgatorio guarda caso parla proprio dei superbi:
Vedea colui che fu nobil creato
[…]
O Nïobè, con che occhi dolenti
[…]
Mostrava ancor lo duro pavimento
Anche nel Paradiso (19. 115-141), nel canto XIX che si svolge nel cielo di Giove, ove risiedono gli spiriti giusti, c’è un altro acrostico, LVE, cioè LUE, ovvero la peste, sintesi del giudizio sui sovrani malvagi e corrotti:
Lí si vedrà, tra l’opere d’Alberto,
[…]
Vedrassi la lussuria e ’l viver molle
[…]
E parrano a ciascun l’opere sozze
Di mesostici, in versi singoli, che danno come soluzione la parola DANTE, Dossena ne riporta cinque contenuti nell’Inferno, fra cui questo:
e Disse A Nesso: «Torna, E sì li guida […] (12. 98) [le maiuscole sono mie]
il più bello, a mio parere, dato che le lettere che formano DANTE stanno in parole contigue, l’una di seguito all’altra.
Il gioco della sostituzione di una vocale con un’altra (amAr/amOr) è sovente praticato da Dante, ad esempio nel Detto d’amore, un poemetto di 480 settenari, collocabile nel 1280, in cui si legge:
Tu mi vuo’ trar d’amare
e di ch’amor amar’è.
Anche nel Purgatorio (27. 132) – ricorda Dossena nella sua Enciclopedia dei giochi – si trova il cambio di vocale:
fuor se’ dell’Erte vie, fuor se’ dell’Arte [le maiuscole sono mie]
A proposito del famoso verso «Pape Satàn, pape Satàn aleppe!» (Inferno, 7. 1), Dossena, non so quanto scherzosamente, sembra dare credibilità a un’ipotesi azzardosa, affermando che forse si comincia a intravedere una lucina spiegando quel verso con il ricorso all’anagramma: pela patate, passa panna, pepe (notevoli la coerenza culinaria e l’allitterazione in P), o forse appena palpate, pena passate (basta una toccatina, e subito arriva il castigo).
D & D. Il Dante di Dossena Leggi tutto »
di Sergio Tardetti
 Quanto conta il titolo di un libro nella decisione di acquistarlo? E in quella di leggerlo? Perché, è inutile, si acquistano molti più libri di quanti se ne possano leggere, magari incuriositi proprio dal titolo, con l’intenzione di prenderli in mano, un giorno o l’altro, e quanto meno di assaggiarli, se non proprio di divorarli fino in fondo. Leggi “Gravità” in copertina ed è subito un richiamo immediato a quella forza che ci consente di stare con i piedi per terra, ma che, per poeti e narratori che amano circondarsi di poesia, è l’ostacolo che impedisce di volare, di librarsi in aria con disinvolta leggerezza. E già fin da questo punto si accendono in testa mille domande: si può essere “gravi” e al tempo stesso leggeri? Si può stare con i piedi per terra e insieme sollevarsi in volo? Si può essere duri e delicati al tempo stesso? Domande necessarie, preparatorie in qualche modo alla lettura di quello che troveremo all’interno, al netto delle conferme e delle smentite.
Quanto conta il titolo di un libro nella decisione di acquistarlo? E in quella di leggerlo? Perché, è inutile, si acquistano molti più libri di quanti se ne possano leggere, magari incuriositi proprio dal titolo, con l’intenzione di prenderli in mano, un giorno o l’altro, e quanto meno di assaggiarli, se non proprio di divorarli fino in fondo. Leggi “Gravità” in copertina ed è subito un richiamo immediato a quella forza che ci consente di stare con i piedi per terra, ma che, per poeti e narratori che amano circondarsi di poesia, è l’ostacolo che impedisce di volare, di librarsi in aria con disinvolta leggerezza. E già fin da questo punto si accendono in testa mille domande: si può essere “gravi” e al tempo stesso leggeri? Si può stare con i piedi per terra e insieme sollevarsi in volo? Si può essere duri e delicati al tempo stesso? Domande necessarie, preparatorie in qualche modo alla lettura di quello che troveremo all’interno, al netto delle conferme e delle smentite.Gravità (recensione) Leggi tutto »
La cooptazione del giudice Sergio Moro nel governo di Jair Bolsonaro in Brasile era decisa da tempo e getta nuove ombre sulla condanna di Lula. Facciamo luce sull’arte del lawfare in America latina.
1) Oggi i media mondiali raccontano come un successo di Jair Bolsonaro l’accettazione da parte del giudice Sergio Moro (rappresentato come un eroe senza macchia e senza paura, che condannò Lula nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato), di diventare ministro della giustizia nel nuovo governo. Superministro dicono, accorpando giustizia e sicurezza, un potere immenso. Giova ricordare che Sergio Moro condannò Lula essendo lui stesso candidato in pectore alla presidenza della Repubblica, partecipando sistematicamente a manifestazioni politiche contro il governo. Oggi sappiamo da una fonte al di sopra di ogni sospetto, niente meno che il vicepresidente di Bolsonaro eletto in Brasile, il generale Hamilton Mourão, apertamente nostalgico del regime civico-militare, che lo dichiara senza pudori o politicismi al quotidiano “Valor Económico”, che l’accordo Moro/Bolsonaro (che evidentemente comportava la desistenza del primo in cambio di un ministero) fosse ben anteriore. Dobbiamo credere alla terzietà di Moro al momento di condannare Lula?
…
Promemoria brasiliano su Bolsonaro, il giudice Moro e il lawfare contro LulaLeggi altro »
Promemoria brasiliano su Bolsonaro, il giudice Moro e il lawfare contro Lula Leggi tutto »