Sempre più, a mio avviso, l’anelito alla “bellezza”, nell’oggi, si manifesta in modo disordinato, caotico, infatti l’incertezza della sua forma e, soprattutto, della sua autenticità, complici le chimere di una società sempre più omologata dalle regole del mercato e dell’apparenza, determina smarrimento, persino paura. È necessario, per questo, agire sull’educazione alla consapevolezza, sull’elevazione del pensiero, poi curare l’estetica dei luoghi e delle persone, come pure dei comportamenti, dei discorsi e delle relazioni. Del resto la bellezza è forse la categoria che meglio incarna “il paradigma della complessità”, quello elaborato dal filosofo e sociologo francese Edgar Morin, così che essa risulta la strada per educare il cittadino, la donna e l’uomo del presente, verso, si confida, un nuovo Umanesimo il quale possa riflettersi, senza timori e senza smarrimenti, nello specchio della storia, nella ricchezza multiforme del patrimonio e dei linguaggi. A questo proposito è importante leggere i testi di Zygmunt Bauman e Agner Heller “La bellezza (non) ci salverà” e di James Hillman “Politica della Bellezza” secondo i quali, appunto la bellezza, risulta l’unico possibile antidoto contro la disperazione, quindi una dimensione inattesa, spaesante sebbene in costante dialogo con il suo opposto, cioè “lo sgradevole”, nonché la sola risultanza positiva in merito alla fondamentale connessione tra benessere collettivo e qualità estetico-etica dei contesti di vita.
Reputo che anche da tali premesse sia nato questo nuovo ciclo di opere di Maurizio Gabbana, cioè il fare della fotografia non un manufatto puramente aggraziato, quindi edonisticamente piacevole, ma uno strumento di indagine che, abbandonando una formulazione tradizionale, entra nel dialettico se non nel concettuale col pittorico, ponendo alla sua base uno scopo specifico, quello di rinnovare una freschezza dello sguardo… di quello sguardo (sul mondo) ormai contaminato e incrostato dalla (in)civiltà delle immagini.
Per Gabbana, come spesso mi ha detto, “l’assenza è visibile”, e, in fotografia, visibilissima, ancor più se la si sottolinea tramite spazi scelti, ben precisi, in modo che “solo l’assenza rende il soggetto dello scatto”… forse un “soggetto anomalo”, come lo definiva il compianto Luigi Ghirri, ma di cui ne percepiamo, ben netta, la presenza, e proprio a seguito della sua scomparsa. Un “soggetto anomalo” in un tempo sospeso… un tempo, tecnicamente parlando, definito “di secondo livello”, ma che pur combacia con l’altro, col “primo”; quel tempo che diviene cifra e bersaglio, per il come attira la nostra massima attenzione, così che nella misura del suo grado di sovrapposizione troviamo il motivo del cosiddetto “tempo palese”, il quale si concretizza in accezione evidente tramite una mancanza voluta, una mancanza creata, quella di cui ho pocanzi detto.
Dunque il vuoto (cioè lo spazio lasciato bianco), in una fotografia, non è mai il nulla, essendo una fotografia, contemporaneamente, una presenza tramite l’indicazione di una pseudo-assenza (cioè quella del soggetto della stessa, quella del soggetto fotografato).
Già sappiamo che Maurizio Gabbana sviluppa costantemente la sua arte esplorando, soprattutto, un’intimità dovuta a una ricerca trascorsa oltremodo in solitaria, costruendo, in questo modo, serie narrative unendo scatti di “reportage” urbano in cui l’umanità è (non a caso) quasi sempre assente, oppure tramite una ricerca simbolica nella quale la figura risulta, unicamente, pretesto scenico, a cui abbinare ciò che in realtà, al nostro fotografo, interessa mettere in evidenza, così che le immagini che risultano riflettono sulle relazioni, sulle origini, sul passato, e, ovviamente, sul sociale, spesso guardando le architetture e i monumenti innalzati dagli umani quindi trasformandoli in pietre angolari dell’analisi svolta, mirando a illustrare l’idea della memoria, il suo impatto sul presente e sul futuro, e anche i suoi limiti, nonché la sua dissolvenza.
Wim Wenders ha detto della fotografia che sulla pellicola si imprime la traccia del fotografo, l’immagine non dei suoi lineamenti esteriori, bensì del suo cuore. Ed è proprio così, e lo è, anche, per Gabbana.
L’inattività, il privarsi di un punto-fuoco, quel vuoto-assenza nel pieno (e in ciò l’ossimoro – innegabilmente – ci ricade) il tutto tipico di un mondo occidentalizzato, massificato e spesso opulento, cattura, di continuo, la sua curiosità, in modo che l’off gli risulta più interessante dell’on. In tale dimensione dell’essere (in arte e non solo) i suoi luoghi divengono irreali, o, meglio, surreali, principalmente nel momento in cui, via via, si vanno a svaporare o sovrapporre, e questo in accezione sempre più pittorica.
Sì, innegabilmente l’assenza, cioè la mancanza, cioè la perdita di valore e di valori, in fotografia, il più delle volte, è solo avvertita, non viene resa concretamente manifesta, ma a Gabbana non basta, lo choc deve essere totale, perciò toglie, cancella, elimina, seleziona. Infatti “le assenze”, in particolare in questi suoi ultimi lavori, sono talmente tangibili, sono a tal punto rese manifeste, che la rappresentazione, in modo universale, di quella sensazione che nel contemporaneo forse è la più comune, la più alienante, risulta alla pari di ciò che, dalla carta, con somma evidenza colorifera, invece emerge. Del resto ben sappiamo che la fotografia, sebbene finemente alterata a posteriori, il più delle volte diventa una delle possibili varianti della nostra percezione, e maggiormente l’immagine risulta simile al reale tanto più l’allegoria ricavata ne sposta i limiti verso un indefinito mondo bidimensionale, che galleggia su quello a tre dimensioni. Quindi ogni fotografia, come ogni elaborazione della stessa, si sostiene su un pilastro di incertezze e interrogativi, e proprio per questo Dacia Maraini così disse: “Le fotografie ci ricordano che il tempo è multiforme e che noi siamo parte di una catastrofe metamorfica”, non a caso fotografare significa cogliere nel mondo, negli oggetti, nella natura, nelle persone, ciò che si è inteso della vita, infatti ogni grande foto ci appare come l’immagine di un’idea… anzi, è l’idea stessa.
La famosa definizione di “profondità abitata”, parte delle teorizzazioni di Savinio e De Chirico per circoscrivere concettualmente la pittura metafisica, mai come ora, anche tramite questi lavori “bipolari” (perché il bianco interagisce col super cromato), aderisce in modo perfetto alle immagini “costruite” da Maurizio Gabbana; si tratta nel vero di “profondità” perché, in esse, si intravede il grande enigma che sta dissezionando quest’epoca di veloci mutamenti e che sta rendendo noi esseri umani come ricordi di un qualcosa… quindi non come presenze, ma come entità “scomparse”; non come risultanze di un presente, ma come fantasmi giunti dal passato.
Il punto di vista ardito, seppur poetico, con cui il nostro artista affronta questi temi punta proprio a mascherare l’essenza del reale proponendo la separazione dallo stesso; una separazione che però lascia tracce tangibili, in grado di impressionare l’immediatezza degli scatti dai quali prendono vita le sue opere.
Da ciò risulta che, in Gabbana, la fotografia non è mai oggettiva visione della realtà, ma documentazione di un punto di vista, così le tinte, le forme o le superfici, che lui ritrova, diventano protagoniste di una messa in scena funzionale alla rappresentazione, in questo caso oserei dire “teatrale”, che nell’artificio va a esplicare la sua massima dichiarazione di intenti.
Quindi in Gabbana la fotografia non rivaleggia con la pittura, ma l’una la si ritrova nell’altra; infatti, come già scrisse la sempre da me amata filosofa americana Susan Sontag, “se il fotografo rivela, il pittore costruisce”… in questo caso mostrandoci l’attualità per poi tentare di dare scheletro a un possibile domani… a un futuro di nuovo socialmente vivibile.
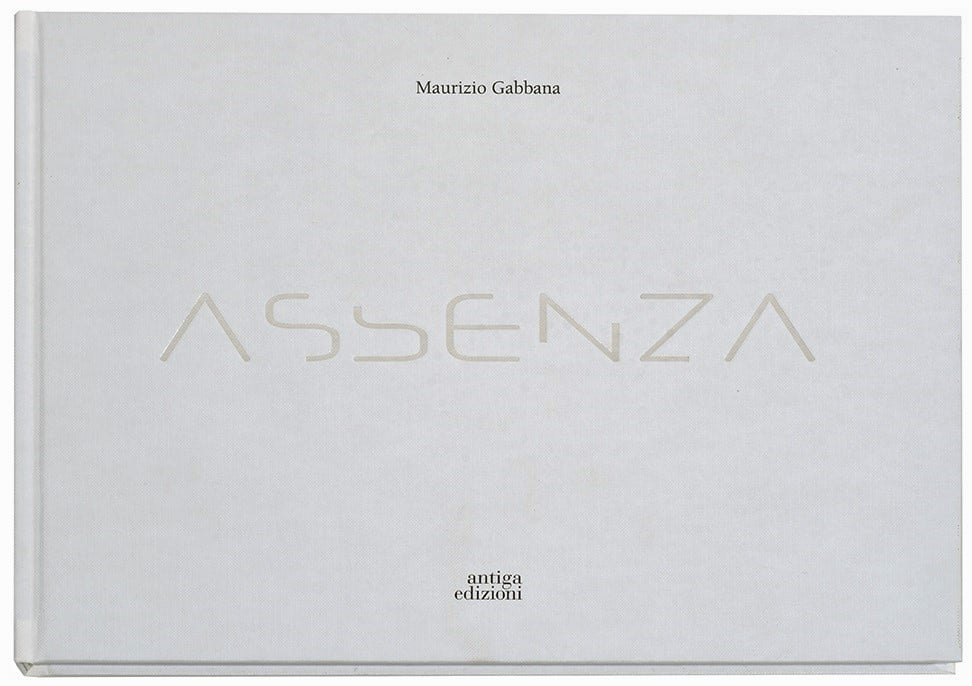
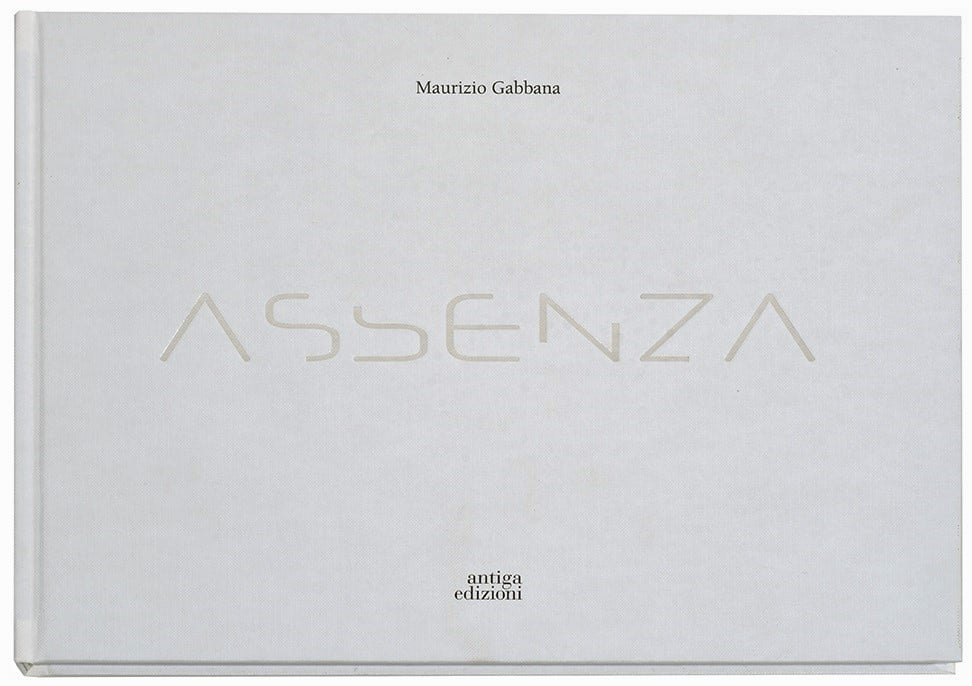
 Dal risvolto di copertina la presentazione della raccolta:
Dal risvolto di copertina la presentazione della raccolta: