I TRENI DELLA VITA
Recensione del libro “LE CAREZZE DEI LAMPI” di Fabio Mongardi
di Sergio Tardetti

Ammetto sinceramente – e confesso – che l’ultimo romanzo di Fabio Mongardi, “Le carezze dei lampi”, mi ha dato molto da riflettere, a cominciare dal titolo. Per l’intero volume ho rincorso l’indizio/ chiave di lettura celato in quel titolo, sperando in una sua incarnazione in una scena, in un avvenimento, in un dialogo, in un personaggio che ne rivelasse l’essenza reale. L’ho rincorso avendo trascurato, per mia distrazione, il fatto che l’enigma si era praticamente chiarito da sé fin dalle prime pagine, con quel riferimento in esergo ai versi di Isacco Turina, la cui citazione, nelle intenzioni dell’autore, voleva essere un suggerimento che indirizzasse verso la comprensione del titolo, e che, di fatto, ha acceso una luce soltanto a lettura avanzata. Dimostrazione questa che, ancora una volta, il lettore va in cerca di qualcosa che si nasconde proprio davanti ai suoi occhi.
Parole del titolo che poi rinviano ad un avvenimento non secondario, che coinvolge due dei protagonisti del romanzo. E qui mi fermerei, per evitare di rivelare eccessivi dettagli della trama e dei personaggi, ma proseguirei piuttosto con considerazioni che sono emerse nel corso della lettura. Una lettura – posso affermarlo senza tema di smentita – che scorre via continua e fluida, non senza lasciare profonde tracce di sé sotto forma di sensazioni e di impressioni, che risultano così note (vorrei dire comuni) a quanti, come me, sono cresciuti e continuano a vivere in un contesto di provincia. L’immagine che mi ha accompagnato per tutto il corso della lettura è stata quella del treno che apre la storia e che poi ne determina lo sviluppo. Da lì a trasformare quell’immagine in metafora dell’esistenza il passo è stato breve, complice un’espressione francese, train de vie, “stile di vita”, che mi è tornata in mente seguendo qualche percorso contorto e accidentato della memoria. Da qui a ricondurla agli accadimenti di una comune esistenza il passo è stato breve.
Così sono le vite di provincia, inquiete nel profondo e fintamente serene di fuori, quella provincia avvertita a volte come ambiente del quale si è prigionieri, ridotti in catene dalle convenzioni di rapporti instaurati nel corso di intere esistenze. Una provincia apparentemente perdente nel confronto con la megalopoli, luogo di sfrenate libertà, dove nessuno ti giudica per quello che sei né per quello che fai, ma in cui ciascuno si tiene a distanza dalle vite di chi l’abita, senza nemmeno tentare di avvertirne lo scorrere sulla pelle. La megalopoli spesso dura e ostile, corazzata contro ogni vizio ma anche contro ogni virtù, indifferente al bene così come al male. Si pensa, invece, alla provincia come a una miriade di piccoli e piccolissimi borghi, dove tutti si conoscono e ognuno sa tutto – o almeno immagina di sapere tutto – di tutti gli altri, dove l’osservanza della regola è elogiata e l’eccezione è considerata devianza dagli schemi sociali imposti da secolari tradizioni e comportamenti. Ed è così che viene chiesto, spesso anche preteso, dalle vite di provincia il rispetto di questi vincoli, dai quali non consentito deviare se non “deragliando”, uscendo cioè dai binari della norma. Tenendo costantemente presente che ci sono sempre, comunque e ovunque, prezzi da pagare per il proprio “train de vie”.
I treni della vita sono quelli che, a volte, decidiamo di prendere, altre volte, invece, di perdere, per libera scelta, per distrazione o perché semplicemente li ignoriamo. Sono treni che, una volta presi, portano un po’ ovunque, a volte ci travolgono, più spesso ci limitiamo a guardarli passare, mentre altri personaggi ne scendono e salgono di continuo. Accade ad ogni esistenza, in ogni luogo. L’incidente rimane in ogni caso l’evento traumatico che cambia vite e destini, quello che fa deragliare il treno, lo fa uscire dai binari della quotidianità e delle abitudini. Le vite subiscono in questo modo uno scossone violento, alcune diventano incontrollabili e irrecuperabili, perché ognuno è legato a tutti gli altri, che lo desideri o no. Complice del “deragliamento” diventa anche la distrazione di chi “guida” questo treno, ma che poi, alla fine, può fare ben poco per evitare l’evento traumatico che costringe a ripensare le vite di molti e a modificarne il percorso attuando nuove scelte e nuove decisioni. “Le carezze dei lampi” è un romanzo “corale”, in cui ogni personaggio è, in qualche modo, oltre che protagonista della propria vicenda personale, anche di quella collettiva, passeggero volontario o involontario, consapevole o meno, di quel treno che sconvolge il piccolo mondo in cui si sviluppa la storia.
Chiudo con un’ultima annotazione, della quale mi corre l’obbligo di non tacere. È interessante sottolineare come il paesaggio, così come minuziosamente descritto, diventa non solo spettatore e fondale animato – nel senso di “dotato di anima” -della vicenda, ma anche esso stesso personaggio, insinuandosi in molte pagine, per attribuire alla narrazione una precisa collocazione spaziale e temporale; un “personaggio” che fa da collante allo sviluppo della trama, rappresentato attraverso descrizioni di tale intensità e realismo che non può essere ignorato né dimenticato, anche molto tempo dopo il termine della lettura.
Fabio Mongardi – Le carezze dei Lampi. Morellini Editore, 2023.
I TRENI DELLA VITA Leggi tutto »

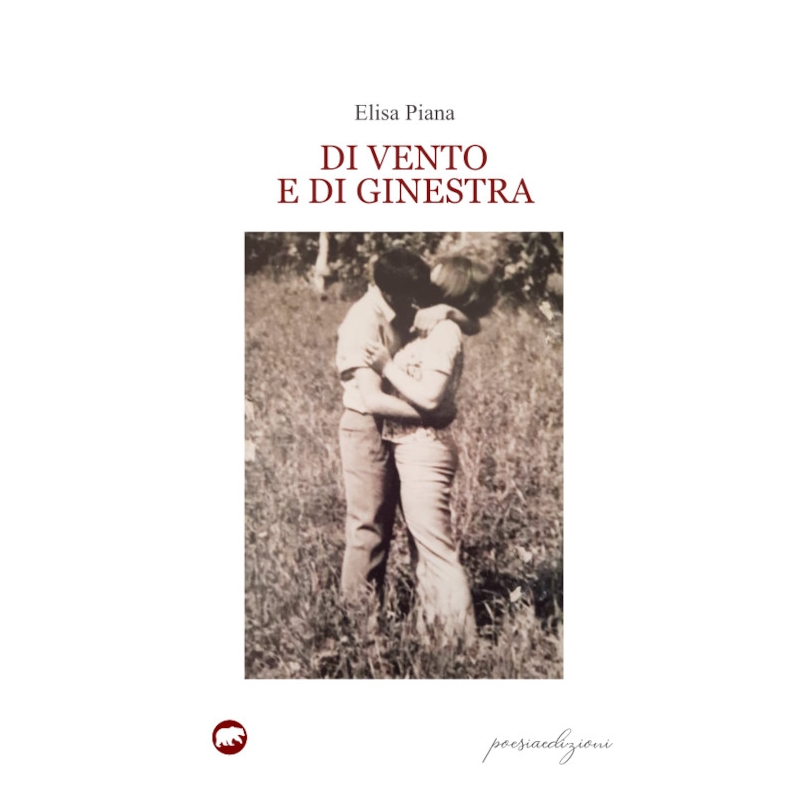
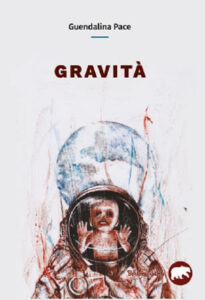 Quanto conta il titolo di un libro nella decisione di acquistarlo? E in quella di leggerlo? Perché, è inutile, si acquistano molti più libri di quanti se ne possano leggere, magari incuriositi proprio dal titolo, con l’intenzione di prenderli in mano, un giorno o l’altro, e quanto meno di assaggiarli, se non proprio di divorarli fino in fondo. Leggi “Gravità” in copertina ed è subito un richiamo immediato a quella forza che ci consente di stare con i piedi per terra, ma che, per poeti e narratori che amano circondarsi di poesia, è l’ostacolo che impedisce di volare, di librarsi in aria con disinvolta leggerezza. E già fin da questo punto si accendono in testa mille domande: si può essere “gravi” e al tempo stesso leggeri? Si può stare con i piedi per terra e insieme sollevarsi in volo? Si può essere duri e delicati al tempo stesso? Domande necessarie, preparatorie in qualche modo alla lettura di quello che troveremo all’interno, al netto delle conferme e delle smentite.
Quanto conta il titolo di un libro nella decisione di acquistarlo? E in quella di leggerlo? Perché, è inutile, si acquistano molti più libri di quanti se ne possano leggere, magari incuriositi proprio dal titolo, con l’intenzione di prenderli in mano, un giorno o l’altro, e quanto meno di assaggiarli, se non proprio di divorarli fino in fondo. Leggi “Gravità” in copertina ed è subito un richiamo immediato a quella forza che ci consente di stare con i piedi per terra, ma che, per poeti e narratori che amano circondarsi di poesia, è l’ostacolo che impedisce di volare, di librarsi in aria con disinvolta leggerezza. E già fin da questo punto si accendono in testa mille domande: si può essere “gravi” e al tempo stesso leggeri? Si può stare con i piedi per terra e insieme sollevarsi in volo? Si può essere duri e delicati al tempo stesso? Domande necessarie, preparatorie in qualche modo alla lettura di quello che troveremo all’interno, al netto delle conferme e delle smentite.